
Non si arresta la morsa dell’inflazione che tiene ormai sotto scacco i Paesi occidentali da ben prima dell’avvio delle operazioni militari in Ucraina e che ha visto solo un inasprimento con l’inizio del conflitto in est Europa. Secondo i dati dell’Eurostat, nel mese di maggio 2022 l’inflazione nell’area euro ha registrato un incremento annuale dell’8,1%, rispetto al 7,4% del mese precedente e al 2% dello stesso mese del 2021.
L’aumento dei beni energetici è stato quello che ha registrato la crescita più elevata con un aumento del 39,2% rispetto a maggio 2021 e del 2% rispetto ad aprile 2022. Mentre su base mensile, i prezzi al consumo hanno registrato un incremento dello 0,8%. In Italia, invece, il tasso d’inflazione a 12 mesi è salito al 6,9% e nel solo mese di maggio l’aumento dei prezzi è stato dello 0,9%. Inoltre, anche la cosiddetta inflazione core – ossia quella al netto dei prodotti energetici e alimentari – si attesta al di sopra del 2%, registrando nel mese di maggio il 3,3%. Una situazione allarmante che erode il potere di acquisto dei cittadini e che minaccia di rallentare la crescita economica: l’impennata dei prezzi, infatti, è dovuta solo in parte all’aumento della domanda di beni e servizi, mentre le cause più rilevanti riguardano le congiunture geopolitiche e la logistica delle catene di approvvigionamento, ossia la componente dell’offerta. Di conseguenza, l’aumento dei costi delle materie prime comporta un rallentamento della produzione, in quanto quest’ultima diventa più costosa e meno redditizia.
Il rischio è che si realizzi ciò che in economia è indicata come “stagflazione”, ossia la presenza congiunta del rialzo dei prezzi e del calo della produzione, una delle condizioni più sfavorevoli a livello macroeconomico. A lanciare un allarme in questo senso è stato l’Ufficio Studi della CGIA già lo scorso marzo, scrivendo che “Il rischio non è immediato, ma il pericolo che la nostra economia stia scivolando lentamente verso questa tempesta perfetta è molto elevato”. Similmente, pochi giorni fa il presidente della JP Morgan, Jamie Dimon, ha ammonito sui rischi di quello che ha definito un “uragano economico”: “In questo momento c’è il sole, le cose vanno bene. Tutti pensano che la Federal Reserve sia in grado di gestire la situazione. Ma l’uragano è proprio là fuori, lungo la strada, e sta venendo verso di noi. Resta solo una cosa da capire se sarà di minore entità e potrà essere declassato a tempesta tropicale o se ci troveremo di fronte a una super-tempesta come Sandy” ha dichiarato. Una prospettiva, dunque, non rassicurante e causata da molteplici e complessi fattori cui si sono aggiunte anche decisioni politiche poco lungimiranti quando non interamente contrarie agli interessi dei cittadini.
Le cause dell’inflazione
Sin dallo scorso anno si è assistito ad uno squilibrio tra domanda e offerta provocato dai colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento globali dovuti ai blocchi della produzione durante il lockdown. Contemporaneamente, il rapido aumento dei prodotti energetici ha influito sia sulla coltivazione dei prodotti agricoli che sul costo dei trasporti andando a pesare sui consumatori finali. In particolare, l’aumento dei costi dell’energia in Europa – già prima dello scoppio del conflitto in Ucraina – è da addebitarsi in buona parte alla modifica dei contratti, voluta fortemente dalla Commissione europea, con i colossi energetici russi come Gazprom. Come ha spiegato Demostenes Floros, Senior Energy Economist presso il Centro Europa Ricerche (CER) e docente all’Università di Bologna in “Relazioni Internazionali” (modulo energia), fino a pochi anni fa i contratti energetici europei con la Russia erano i cosiddetti “oil-link”: in questo tipo di contratti il prezzo del gas era legato all’andamento dei costi di un paniere di prodotti petroliferi e veniva prevista la fornitura/acquisto di un determinato quantitativo di gas ad un prezzo concordato e tendenzialmente stabile. Si tratta dei cosiddetti contratti a lungo termine. Successivamente l’UE ha deciso di passare ai contratti “spot”, in cui, invece, il prezzo è determinato dalle dinamiche di domanda e offerta del mercato. Questa decisione venne presa sulla base degli attriti geopolitici con la Russia pensando di colpire Gazprom, ma in realtà, quella decisione si è ritorta contro i consumatori europei. Come ha spiegato lo stesso Floros, infatti: “l’Unione europea riteneva scioccamente di mettere in grossa difficoltà la Federazione russa, la quale invece si adeguò velocemente al nuovo contesto, senza tenere conto dei rischi ai quali l’Unione andava incontro. E dire che il responsabile dei contratti della Gazprom, Sergey Komlev, più volte, durante i suoi interventi in Italia (Forum Italia-Russia di Milano, Forum Eurasiatico di Verona, Forum NE-Nomisma Energia di Bologna), ci aveva messi apertamente in guardia sulle possibili conseguenze negative”. Infatti, a seguito del cambio di modello contrattuale, i prezzi sono aumentati a causa delle dinamiche di mercato, mentre l’estate scorsa l’incremento della domanda di gas, per via del precedente inverno rigido che ha esaurito le scorte, ha provocato un’ulteriore impennata dei prezzi. L’aumento del costo dei prodotti energetici si è riversato sia sulla produzione industriale che su quella dei beni alimentari: nel primo caso, infatti, l’inevitabile aumento dei costi di produzione incide sul prezzo finale dei beni di consumo. Nel secondo, invece, l’incremento del prezzo del gas ha inciso sui costi dei fertilizzanti, indispensabili per la produzione agricola.
Ad aggravare ulteriormente questo già preoccupante scenario è stata, in seguito allo scoppio della guerra, la decisione dell’Unione europea di sanzionare economicamente le importazioni dei prodotti energetici russi: come già spiegato in precedenti articoli, tali sanzioni economiche hanno avuto conseguenze asimmetriche, finendo paradossalmente per danneggiare più i Paesi europei che Mosca. Infatti, la riduzione dell’offerta di gas e petrolio russo ha comportato un aumento dei prezzi, dovuto anche alle speculazioni finanziarie. In questo modo, Gazprom ha più che compensato la riduzione delle esportazioni con la crescita dei costi causata proprio in buona parte all’effetto delle stesse sanzioni. Allo stesso tempo, il blocco nei porti ucraini delle materie prime alimentari come grano e mais – dovuto ai campi di mine piazzate dall’esercito di Kiev per contrastare eventuali azioni anfibie russe – potrebbe comportare una crisi alimentare nei prossimi mesi, con conseguente rialzo dei prezzi, su cui scommettono gli speculatori del mercato dei futures. La speculazione finanziaria, infatti, è una causa primaria tra quelle che concorrono all’inflazione sia energetica che alimentare. I contratti futures si basano sulla scommessa al rialzo o al ribasso delle commodities (come grano, oro, metallo o petrolio) che costituiscono l’attività sottostante del contratto stesso: secondo molti esperti del settore queste scommesse hanno il potere di determinare un aumento di tali commodities sul mercato reale, come accaduto per l’aumento del costo del petrolio nel 2008. Risulta evidente, dunque, la necessità di una maggiore regolamentazione dei mercati finanziari per evitare che pochi si arricchiscano sulla pelle di molti.
Le previsioni del FMI e della Banca Mondiale
Tutti questi fattori hanno spinto le Istituzioni finanziarie internazionali come l’FMI e la Banca Mondiale a rivedere al ribasso le stime di crescita dell’economia globale, non senza lanciare preoccupanti allarmi circa i disordini sociali che le carenze alimentari potrebbero comportare soprattutto nei Paesi del terzo mondo.
Il FMI ha rivisto le stime di crescita del PIL mondiale al 3,6% sia per il 2022 che per il 2023, con tagli di 0,8 punti sul 2022 e di 0,2 punti sul 2023 rispetto alle stime di gennaio. In particolare, nel World Economic Outlook tracciato dal FMI lo scorso aprile si prevede che le economie europee, tra cui al primo posto quelle di Germania e Italia, saranno tra le più colpite soprattutto rispetto agli Stati Uniti e alle altre principali economie avanzate. Tra i principali elementi del previsto rallentamento dell’economia europea vi sono le sanzioni economiche a Mosca e, dunque, un possibile stop dei flussi energetici dalla Russia che provocherebbe “significative perdite per molte economie”. Sul sito dell’FMI si legge quindi che: “Le prospettive di crescita di quest’anno per l’Unione Europea sono state riviste al ribasso di 1,1 punti percentuali a causa degli effetti indiretti della guerra, rendendola il secondo maggior contributore alla revisione generale al ribasso”. Quanto all’inflazione, si prevede che rimarrà elevata a lungo, precisando che “ha raggiunto il livello più elevato in oltre 40 anni, in un contesto di mercato del lavoro ristretto”.
Ancora più basse sono le stime di crescita globale previste dalla Banca Mondiale per il 2022: nel mese di aprile sono infatti state abbassate al 3.2% rispetto alla previsione di gennaio del 4,1%. Il presidente David Malpass ha affermato di essere “profondamente preoccupato per i paesi in via di sviluppo. Stanno affrontando improvvisi aumenti dei prezzi di energia, fertilizzanti e cibo”. L’Istituto ha, dunque, annunciato un pacchetto di misure da 170 miliardi di dollari per rispondere alla crisi, superiore a quello da 157 miliardi dispiegato per il Covid e che dovrebbe coprire il periodo da aprile 2022 fino a giugno 2023.
La risposta all’inflazione delle banche centrali
Sia la BCE che la Federal Reserve americana si stanno muovendo nella direzione di un rialzo dei tassi di interesse (ossia del costo del denaro): infatti, le politiche monetarie che in genere vengono adottate per contenere l’inflazione sono quelle restrittive, ossia che tendono a drenare liquidità dal sistema economico, riducendo l’offerta di moneta. Questo però ha anche l’effetto collaterale di rallentare la crescita economica e in un momento come quello attuale in cui l’obiettivo è, al contrario, quello di rilanciare l’economia, ciò va esattamente nella direzione opposta. Specie se si considera che in Europa le cause inflazionistiche riguardano solo in parte l’aumento della massa monetaria in circolazione – e quindi la domanda di beni e servizi – e maggiormente fattori esterni di tipo geopolitico e speculativo ed è su questi, dunque, che bisognerebbe intervenire. Lo stesso governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle sue Considerazioni finali 2022, parlando d’inflazione, ha osservato che la politica monetaria “non può contrastare l’aumento dei costi delle materie prime”. Nonostante ciò, ha asserito che l’attuale situazione congiunturale “rende opportuno abbandonare la politica di tassi ufficiali negativi”, che è quella seguita dalla BCE dall’inizio della pandemia. La presidente della Banca Centrale Christine Lagarde non a caso verso la fine di maggio ha reso noto che si appresta a ridiscutere un rialzo dei tassi alla riunione di luglio, in modo da poter “essere in grado di uscire dai tassi d’interesse negativi entro la fine del terzo trimestre”.
Il presidente della Fed Jerome Powell si appresta ad attuare le stesse misure: anche in America, infatti, l’inflazione sta diminuendo notevolmente il potere d’acquisto degli americani. Ciò ha comportato anche un crollo di consenso – già non molto elevato – verso il Presidente Biden: il che è molto pericoloso se si considera che le elezioni di medio termine americane sono alle porte. Nel caso americano, i trilioni di dollari di aiuti contro il Covid 19 immessi nell’economia hanno incrementato la spesa dei consumatori, contribuendo all’aumento dei prezzi. Per questo, la FED ha già alzato i tassi d’interesse di tre quarti di punto quest’anno e prevede di aumentarli ancora di mezzo punto nelle prossime due riunioni, la prima delle quali si terrà a metà giugno. Powell vede il controllo dell’inflazione come la massima priorità economica del Paese, anche se le misure per contrastarla potrebbero comportare un aumento del tasso di disoccupazione.
Nonostante l’inflazione abbia colpito tanto i Paesi europei quanto gli Stati Uniti, è previsto che l’economia europea subirà una frenata maggiore rispetto a quella statunitense, anche e soprattutto per via dei rapporti economici e commerciali che le aziende europee intrattengono con la Russia, oltreché per la sua dipendenza energetica da Mosca. Il rapporto dell’Europa con Mosca non è confrontabile, infatti, con quello che gli Stati Uniti intrattengono con il gigante eurasiatico: la Russia è storicamente parte integrante del continente europeo – come ribadito recentemente al forum di Davos anche da Henry Kissinger – e affossare bruscamente le relazioni commerciali attraverso le sanzioni si sta rivelando controproducente. Per questo, a dispetto di tutti i proclami fatti da Bruxelles, si continua a importare gas russo – sebbene ad un costo maggiore – e l’embargo sul petrolio non entrerà in vigore se non alla fine del 2022 e con rilevanti eccezioni per quanto riguarda l’oleodotto Druzba, il più lungo del mondo che serve i Paesi dell’est Europa, tra cui Ucraina, Ungheria e Polonia. Inoltre, le sanzioni, alla luce dei fatti, non sono servite e non serviranno a fermare la guerra né a far fallire Mosca, come preventivato dai governi occidentali. Sono però sicuramente servite ad alimentare quella spirale inflazionistica che sta affliggendo il Vecchio continente, sul quale aleggia lo spettro della stagflazione. La poca lungimiranza della diplomazia europea – appiattita sulle posizioni statunitensi – in materia di relazioni internazionali e la completa deregolamentazione dei mercati finanziari che speculano sul cibo stanno conducendo, da un lato, ad una “tempesta economica” nel continente europeo e, dall’altro, ad affamare i Paesi poveri. Il tutto danneggerà le famiglie a basso reddito a livello globale e ridurrà ancora di più il potere d’acquisto e le dimensioni della classe media nelle cosiddette economie avanzate. Da ciò si evince che la priorità assoluta passa dal rilancio del dialogo e delle trattative diplomatiche, le quali oltre a determinare un cessate il fuoco, potrebbero ripristinare, seppure faticosamente, i rapporti commerciali con Mosca. Considerato, infatti, che la Russia è il quinto partner commerciale della Ue e che è anche uno dei principali Paesi esportatori mondiali di materie prime, un recupero delle relazioni commerciali inciderebbe di più sulla ripresa economica e sul calo dell’inflazione rispetto a qualunque misura di politica monetaria delle banche centrali.
[Pubblicato su L’Indipendente.online – di Giorgia Audiello]
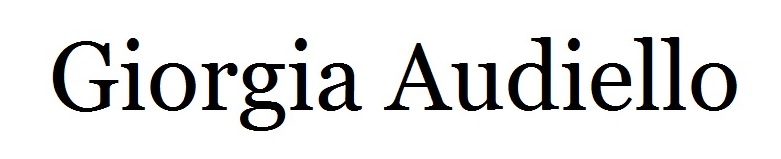
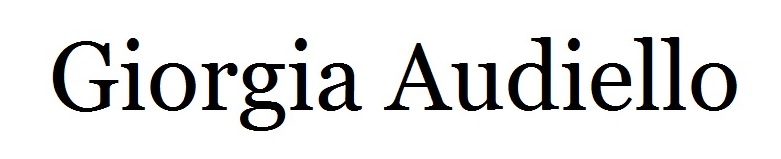



Bella analisi coerente e pragmatica.
Certo io non faccio testo in quanto molto ignorante in materia ma Kairospartners.com/video-e-notizie/il-rosso-e-il-nero lo narrano nello stesso modo ricercando anche l’origine del “problema”.
L’evoluzione è poi complessa e certo non indolore. Molto dipende dalle mosse dei politici e dalla rapidità con cui saranno fatte perchè per la gente normale svuotare il portafoglio è un problema ma per gli stati che ci fanno cassa può andar bene. Finchè dura…
Complimenti!
Grazie!